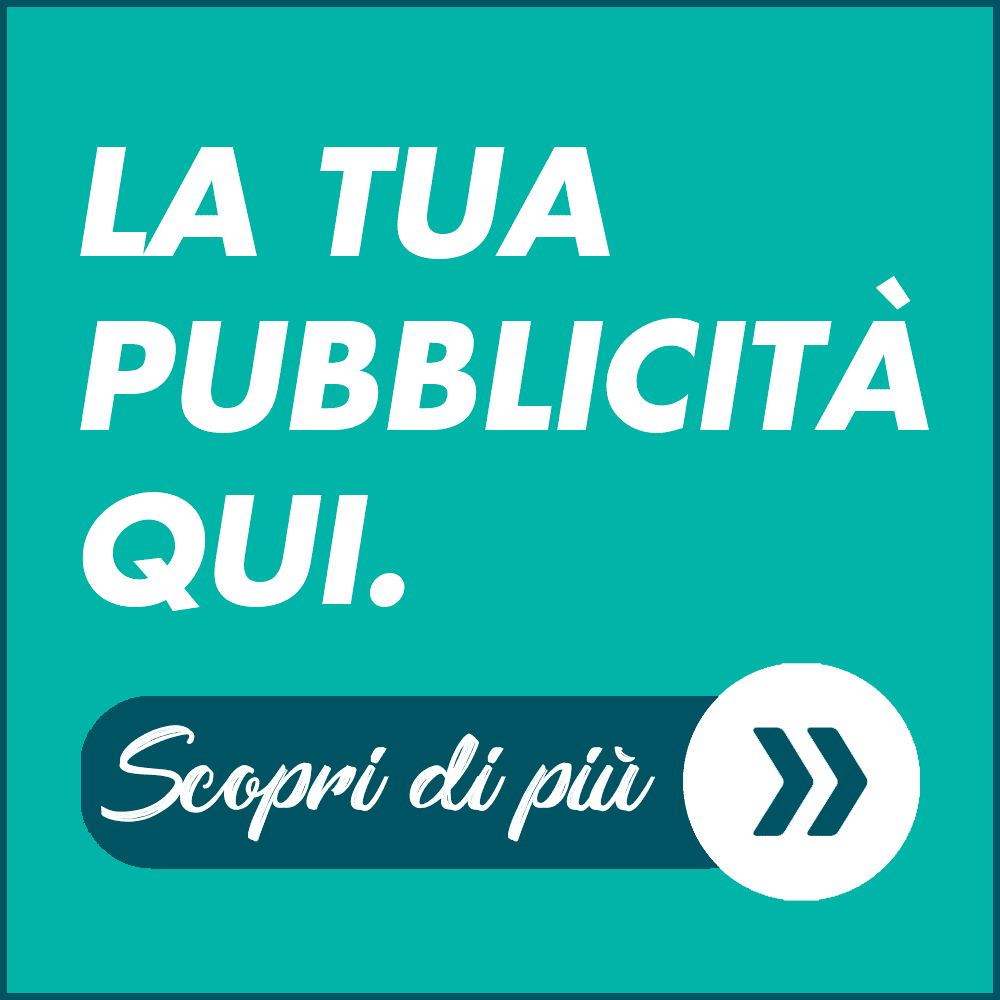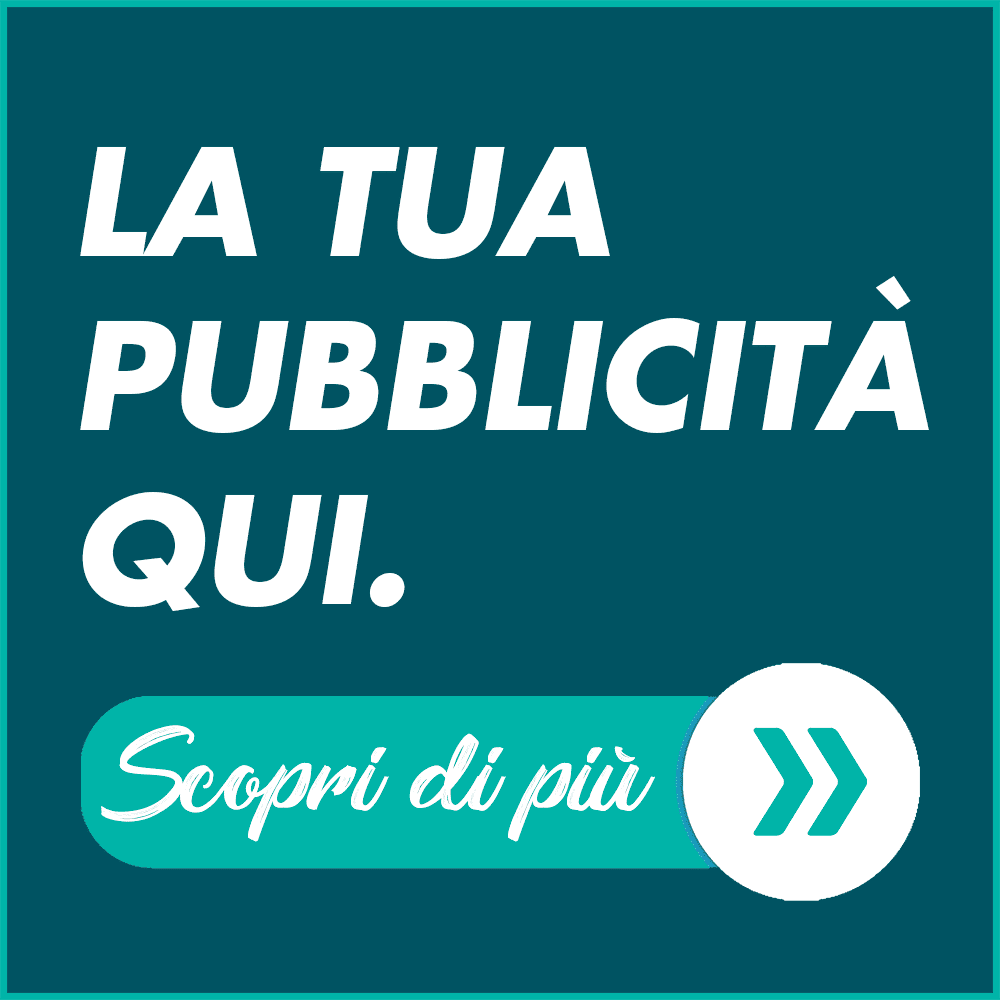Dal Vallo di Diano a Kabul, la guerra in Afghanistan raccontata dal giornalista Lorenzo Peluso
| di Marianna Vallone
Lorenzo Peluso è un giornalista del Corriere del Mezzogiorno e Radio Alfa, ma è anche direttore del quotidiano Quasimezzogiorno.it, e a Uno Tv conduce il programma settimanale ‘In prima persona’. Pochi giorni fa, dopo il Kosovo e Libano, è rientrato dalla missione in Afghanistan, come inviato di guerra. Quello che appare subito chiaro dal suo racconto è che forse noi, qui, abbiamo una percezione diversa del dramma che si vive in Medio Oriente, spesso veicolato da notizie che non raccontano la verità o non la raccontano fino in fondo. In questa intervista Lorenzo racconta la sua recente esperienza, gli incontri con i militari italiani. Ma anche la passione per questo mestiere e la voglia di conoscere e continuare a informare.
Sei da poco rientrato dall’Afghanistan. Dopo la missione in Kosovo e Libano hai deciso di affrontare, come inviato di guerra, una delle realtà più difficili del Medio Oriente. Cosa ti sei portato dentro come uomo e cosa ha invece significato professionalmente questa esperienza.
Certamente gli sguardi ed i volti di quei bambini incontrati nei villaggi dell’Afghanistan. Una terra particolare che ti lascia una sensazione malinconica, quando poi la lasci. Ti affascina da subito. La luce particolare ed un paesaggio per certi versi lunare. La semplicità di una povertà che si “tocca”. Le donne, i burqa, le strade polverose. I volti, che raccontano nel silenzio piccole grandi storie.
E’ entrato nelle nostre case dopo la tragedia dell’11 settembre a New York. L’Afganistan, un Paese quasi sconosciuto che all’improvviso diventa una propaggine dell’Italia. Kabul, Kandahar, Herat, città un tempo sconosciute, oggi fanno parte della nostra quotidianità. La guerra che ci raccontano, è la stessa guerra che si vive lì?
Purtroppo, oserei dire, che in teatro è anche peggio di ciò che riusciamo a percepire qui in Italia. L’Afghanistan non ha ancora chiuso i conti con la sua travagliata storia recente. Un Paese che non ha un’anima identitaria. Un popolo fatto di popoli che nelle loro appartenenze etniche trova il simbolismo dell’individualità dei singoli villaggi; delle diverse zone del Paese. La delicata stabilità economica che dal 2002, anno in cui con l’intervento delle truppe americane a caccia del terrorista Osama Bin Laden, fu rovesciato il governo talebano, e quindi dopo anni di esilio forzato, ora fa i conti con almeno 5.2 milioni di rifugiati provenienti dal vicino Iran e dal Pakistan che hanno fatto rientro in Patria. Ecco perché il futuro di questo Paese, 30milioni di abitanti, rimane incerto. E’ la fame e la mancanza di prospettive a far paura davvero in Afghanistan, certo uno dei paesi più poveri al mondo. Un tema sociale troppo forte per non creare preoccupazione nella comunità internazionale che comunque ha già annunciato che anche se i contingenti militari si ritireranno, in sostanza non si lascerà solo questo Paese. La possibilità che spinte integraliste di matrice talebana si allarghino a macchia d’olio, spaventa l’occidente, con ragione. E poi tutto il lavoro fatto in questi anni per ridare dignità e diritti ad un popolo martoriato, che fine farebbe?
Cosa vuol dire per un giornalista che scrive di un territorio come il Cilento e Vallo di Diano, ritrovarsi a dover raccontare un teatro di guerra come l’Afghanistan.
Intanto è certamente un’esperienza umana che ti segna la vita. Poi, certamente, una grande esperienza professionale. Io credo che chi decide di fare questo mestiere, ha dentro di se qualche cosa di particolare. La voglia di conoscere, prim’ancora che la necessità di raccontare. Credo che questo spirito di scoperta, la curiosità di sapere, trovano in Afghanistan un teatro assolutamente appagante. Troppe le sfumature da cogliere; anzi il rischio è quello di rimanere imbambolati e non riuscire a cogliere l’essenza del momento. Lo scenario è mutevole; costantemente ed ogni singolo momento diviene un pezzo di una piccola grande storia da raccontare. Insomma, diciamo che c’è una certa distanza dal lavoro che facciamo ogni giorno nel nostro territorio anche se l’essenza del fotografare e raccontare, quella rimane immutata, in ogni angolo del mondo.
Di recente hai raccontato sul quotidiano di cui sei direttore due belle storie. Quella di Vincenzo Palermo, un giovane sergente dell’Aeronautica militare italiana, originario di Buonabitacolo e ora in missione a Kabul. E quella di tuo nonno, un artigliere della Littorio, partito a 19 anni per la Cirenaica. Cosa hai provato nell’incontrare e intervistare un tuo conterraneo in una zona di guerra e cosa provi nel raccontare una guerra che invece ti è stata raccontata.
Di Vincenzo, intanto ricordo la sua grande compostezza. Un ragazzo del sud di cui andare orgogliosi. La sua, tra l’altro, è una storia di riscatto, molto particolare. Alcune vicende legate alla sua famiglia, che ho inteso non rendere note, se possibile ne fanno un ragazzo ancor più coraggioso. Poi, fa sempre piacere incontrare gente della propria terra, soprattutto in un teatro così particolare. Mi ha colpito molto l’atteggiamento di orgoglio nel raccontare il suo delicato lavoro. Il fatto stesso di mettere al primo posto, la responsabilità per la vita dei piloti in volo e poi quella vena di prezioso orgoglio nel servire il proprio Paese, facendo quello che si vuole fare, ha reso l’incontro con il sergente Palermo, come dire, istruttivo. Mio nonno è altra storia. In realtà credo che neppure noi italiani abbiamo definitivamente chiuso i conti con i tragici fatti legati all’ultimo Conflitto mondiale. Troppe cose non sono state dette. Troppi dolori sono stati lasciati alla cura del tempo. I fatti di El Alamein, spogliati delle grandi responsabilità attribuibili ai gerarchi ed ai generali che il fronte non lo hanno visto neppure, non hanno reso i giusti onori a quei 25mila ragazzi morti, feriti e dispersi. Non hanno reso onore alle sofferenze di quei 30mila prigionieri lasciati alla mercé degli inglesi. Insomma, credo che per certi versi ci sia bisogno di raccogliere i ricordi di quei reduci che ancora vivono, prima che sia troppo tardi, per raccontare un pezzo di storia che manca ancora di un finale. Di mio nonno poi, vado orgoglioso perché era un giovane valoroso in Africa ed un nonno straordinario che non aveva paura nel commuoversi quando mi raccontava dei giovani commilitoni che aveva visto morire. Le guerre, non sono mai facili da raccontare. Io provo solo a farlo, ma sono convinto di non esserne capace.
Come si fa per diventare inviato di guerra?
Ma intanto, occorre volerlo. In sostanza occorre decidere prima con se stessi che è quello che si vuole fare, accettando una serie di circostanze che potrebbero cambiare la tua vita e quella delle persone che ti sono più care. Poi, per diventare giornalista embedded occorre fare un corso per giornalisti di professione proposto dalla Federazione Nazionale della Stampa unitamente allo Stato Maggiore della Difesa. Questo consente di chiedere l’accredito presso la nostra Difesa e quindi chiedere di effettuare missioni in teatro dove sono presenti militari del nostro Contingente. Poi preparare la valigia e magari farsi apprezzare per il proprio lavoro.
Il lavoro dei nostri militari è enorme. Forse molti non lo sanno, ma la realizzazione degli ospedali di Herat, l’aeroporto o la sistemazione di numerose strade è frutto del lavoro delle truppe italiane. Cosa ti hanno raccontato i nostri militari? Cosa temono? Come vivono i rapporti con la popolazione locale?
Intanto va detto che i nostri militari impegnati nei diversi teatri operativi sono uno dei punti d’orgoglio del nostro Paese. Grandi professionisti che rispetto ai Contingenti di altri Paesi, ovunque, riescono a lasciare segni indelebili della loro grande umanità. Il loro essere italiani è certo un punto di vantaggio nei rapporti con le popolazioni indigene. Purtroppo però quando si opera in terre martoriate da conflitti il sangue da versare tocca a tutti e quindi anche ai nostri. In Afghanistan in nove anni abbiamo lasciato 53 ragazzi. Nel loro ricordo quotidiano i nostri militari si impegnano ogni giorno per onorare la loro memoria e far si che le loro morti non siano vane. Quello che distingue i nostri militari in teatro, rispetto ai commilitoni di altre nazioni, è l’approccio rispettoso del Paese, della religione, degli usi, degli uomini e delle donne che hanno le loro storie. In sostanza noi siamo impegnati in terre martoriate per aiutare e non per imporre la nostra “democrazia” che spesso non è quello di cui questi popoli hanno bisogno. Sul cosa temono, c’è poco da dire. Quando il contesto in cui si opera offre ogni giorno scene di morte e di devastazione, attentati, attacchi kamikaze e ordigni piazzati lungo le strade per fare del male, allora la vita assume un valore diverso e sai che ogni giorno va vissuto nel migliore dei modi.
Di tutte le esperienze da inviato di guerra fatte finora, quale non riferesti? Dove non ritorneresti e dove invece hai lasciato una parte di te?
Ritornerei e ritornerò in tutti i teatri. E’ il mio lavoro. No, non vi è un posto dove non ritornerei. In ogni paese, in ogni villaggio ho strappato qualche cosa di profondo che porto dentro di me. In ogni teatro ho lasciato un pezzo di me. Ognuno diverso, certo. Gli orfani di “Camp Garibaldi”, in Kosovo e gli adolescenti serbi e albanesi che si combattono sul ponte Ibar a Mitrovica. Gli occhi di ghiaccio dei militari israeliani lungo la Blue Line ed i bambini mutilati dalle mine in Libano. La sconvolgente ed affascinante bellezza notturna di Beirut e i burqa di Herat, in Afghanistan. Spero di rivedere tutti e tutto, magari senza indossare elmetto e giubbotto antiproiettile, questo si.
La prossima missione?
Non so ancora dove, ne quando. Ma certo i fatti recenti del Caucaso pure vanno raccontati. In realtà ora sto lavorando ad un viaggio in Romania, per raccontare però le vite e le storie di giovani e donne che in Italia hanno trovato la loro America. Muratori, boscaioli, badanti scappati dalla povertà per fare qui in Italia i lavori che gli italiani non vogliono più fare. Questo è il progetto in cantiere che dovrei realizzare tra qualche settimana.
L’intervista è finita ma mi resta un’ultima curiosità, una domanda un po’ sentimentale. Quando chiudi la porta di casa, saluti tua moglie e tuo figlio. Ti lasci dietro alle spalle il paese in cui vivi, Sanza. Qual è la sensazione che ti accompagna fino all’aeroporto? E soprattutto, qual è quella che provi quando dopo settimane ritorni a casa.
La partenza è sempre un momento di cambiamento, nelle vite di ognuno di noi. Cerco sempre di non fermarmi troppo, per i saluti. Sinceramente non mi piace. E poi parto per ritornare, quindi a che serve salutarsi. In realtà, quando si va in teatro, magari è utile lasciare i propri cari senza grossi problemi da risolvere. La mia abitudine è quella di lasciare una lettera a mio figlio, che non deve aprire. In quella lettera lascio i miei pensieri. Lettere che per fortuna rimangono chiuse e che quindi al mio ritorno vengono conservate, così come sono, sigillate.
©
Twitter @MariannaVallone
©Riproduzione riservata