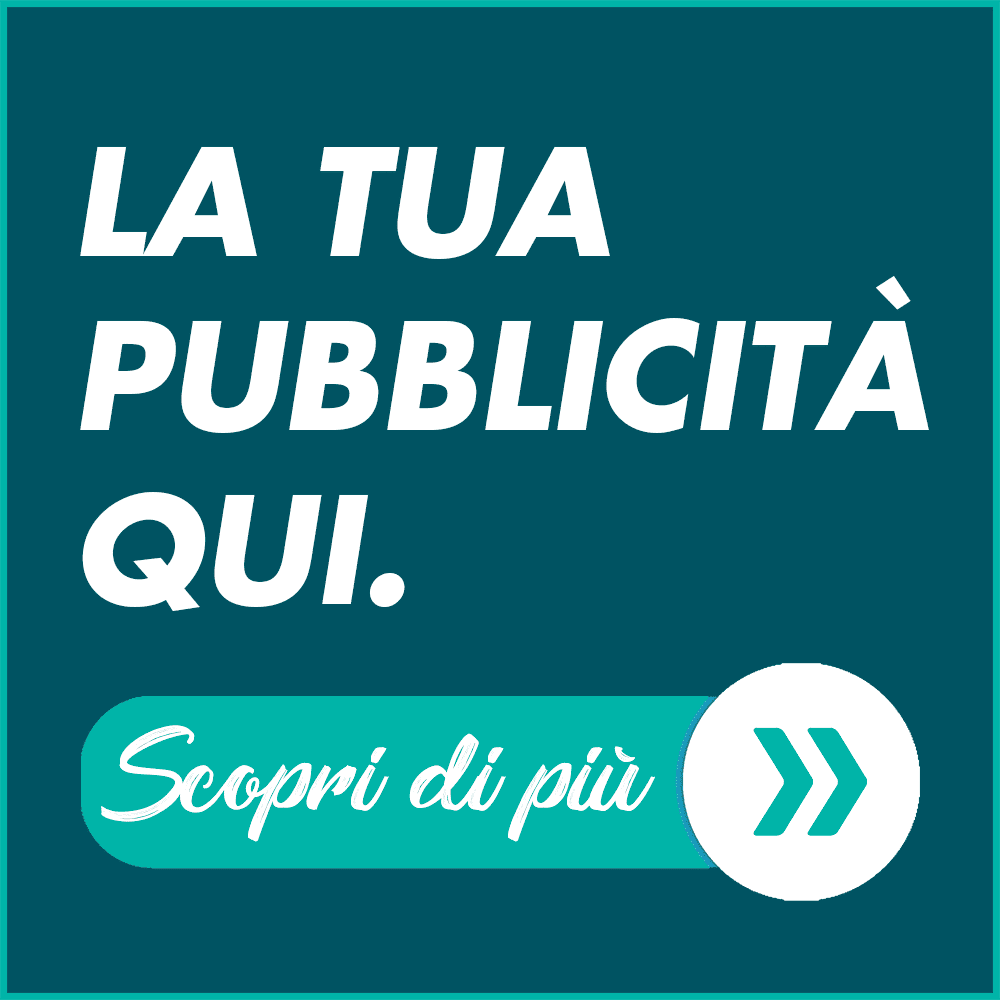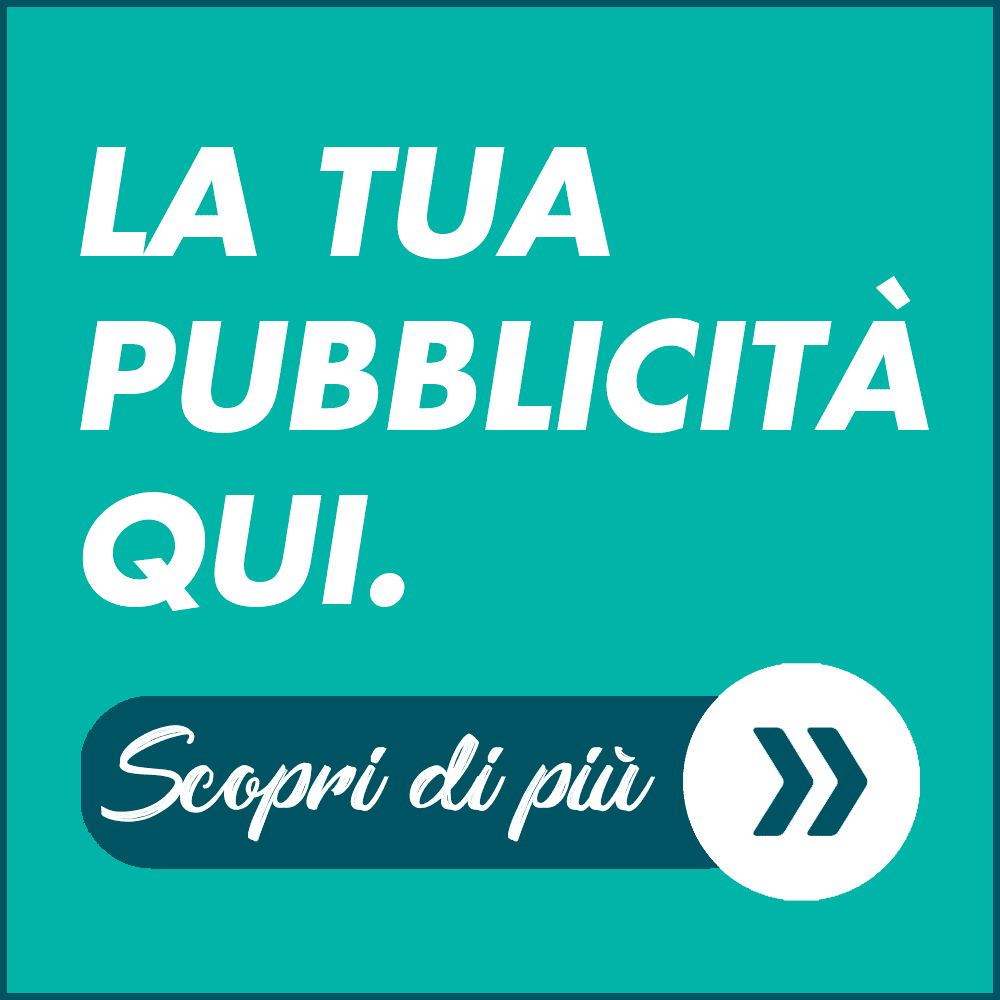Cilentani nel Mondo, ecco Giuseppina Stifano. Da Vallo alla Boston University: è sua una scoperta straordinaria nel campo della ricerca medica
| di Francesco Chirico
E’ il ‘numero zero’ di una rubrica. Terra di grandi bellezze ma anche di grossi contrasti, il Cilento viene spesso etichettato come «arretrato». Chi viaggia, avrà occasione di constatare che per molti aspetti questo aggettivo non è improprio, soprattutto se relativo agli ultimi trent’anni. Questa iniziativa è una ‘finestra aperta’ sui ‘cilentani nel mondo”, il racconto di chi, fuori dal Cilento, ha incontrato opportunità.
Nata a Vallo della Lucania, attualmente ‘instructor of medicine’ (corpo docente) alla Boston University, Giuseppina Stifano, ha deciso di non mollare e la sua ricerca è finanziata da un training grant dell’Nih, ente nazionale americano di ricerca. Questo finanziamento è dato alle giovani ‘promesse’ in formazione con l’intento di formare ricercatori in grado di diventare indipendenti e continuare la loro ricerca. Ha da poco brevettato un marker, per una malattia autoimmune, che aiuterebbe a comprendere e prevedere il decorso della malattia. Cosa fino ad ora impossibile. Giuseppina, dopo aver vinto diversi riconoscimenti in Italia arriva negli States. Il giornale del Cilento l’ha incontrata.
Dal Cilento agli Usa, come ci sei arrivata?
Sono arrivata negli Stati Uniti per due importanti motivi: uno per una passione, il mio lavoro. Io sono un immunologo clinico. A Roma, dove ho studiato medicina e mi sono specializzata in Allergologia e Immunologia clinica, ho avuto la grande opportunità di vedere tantissimi pazienti con una malattia autoimmune, sclerosi sistemica conosciuta anche come sclerodermia. Una malattia di difficile diagnosi di cui non si conoscono le cause. L’ultimo anno di scuola di specializzazione, ho deciso di preparare una tesi di ricerca, e per contratto potevo partire per l’estero finanziata dall’Italia e quindi ho scelto l’America. Il mio sogno era lavorare col professore Robert Lafyatis, che si occupa di questa malattia alla Boston university. Il laboratorio del professore Lafyatis è uno dei più grandi centri mondiali per lo studio di questa malattia. Sono riuscita a contattare Lafyatis, e a incontrarlo a un convegno a Firenze. Il secondo motivo è stato per amore, mio marito è italo/cilentano-americano. Nato e cresciuto a New York, da genitori emigrati da Novi Velia. Ci siamo conosciuti per caso una sera di ferragosto in Italia, nel Cilento. Allora eravamo entrambi in vacanza. Ci siamo subito innamorati, lui dopo pochi mesi si è trasferito in Italia. Siamo stati a Roma per quasi 3 anni, e quando ho avuto la possibilità di scegliere dove andare per preparare la mia tesi di specializzazione, non ho avuto dubbi nello scegliere l’America, per lui era ritornare a casa.
Com’è stato l’impatto con gli States venendo dalla realtà cilentana?
I primi mesi a Boston sono stati faticosissimi. Sono arrivata nel novembre del 2010. Il freddo e la neve, temperature completamente diverse dal clima mite del Cilento, mi hanno proprio temprata nel corpo e nello spirito. Poi la lingua, che angoscia! Diciamo che l’inglese che impari a scuola è un tantino diverso da quello parlato. Ma gli americani e le persone che ho incontrato sono stati fantastici. Poi a Boston ho trovato una bella comunità di italiani, nuove e vecchie generazioni, che nei momenti di forte nostalgia e di necessita`, mi hanno sempre aiutata. I miei amici italiani, emigranti come me, sono davvero importanti e so che posso contare su di loro. Mi hanno detto che ci vogliono almeno 5 anni per riuscire a sentirsi ‘a casa’ io ci sono quasi.
Si può dire che questa esperienza ti ha cambiato la vita?
Certo che questa esperienza mi ha cambiato la vita. Rispetto ‘al prima’ sono molto meno polemica e molto più pragmatica. Ma forse sono anche cresciuta. Penso al domani, prefissandomi goals che sono convinta di poter raggiungere, anche se non so come, quando e dove. In America le condizioni che ti circondano cambiano di continuo, ma questo è un bene, ti costringono a metterti in gioco sempre, e a me piace.
Per raggiungere i tuoi risultati c’è sicuramente bisogno di grande impegno, convinzione, da dove nasce la tua voglia di fare il medico?
Io ero una di quelle bimbe che diceva ‘da grande farò il dottore’. Non conoscevo la differenza tra medico e dottore allora. Tutti sapevano cosa regalarmi a natale o al mio compleanno: una valigetta da pronto soccorso, o uno stetoscopio giocattolo. Il kit da medico era quello che compravo ogni anno sulle bancarelle alla festa di San Pantaleone. Purtroppo ho perso mio padre da piccolina e sono cresciuta con un grande desiderio di aiutare le persone che stanno male. Io sono l’ultima di 4 figli. Inoltre io sono cresciuta in ‘ospedale’ dove la mia mamma lavorava, nel reparto di malattie infettive. Dalle scuole elementari Aldo Moro, spesso da sola andavo in ospedale, dove ormai mi conoscevano tutti, dal porterie al cuochi della cucina. Che meraviglia erano quegli anni. I medici, gli infermieri e i portantini colleghi della mia mamma erano come un’altra famiglia per me e i miei fratelli. Non è un caso che mio fratello il più grande Antonio sia un infermiere, all’ospedale di Vallo. Gennaro un tecnico di radiologia al Gemelli a Roma, e mia sorella Silvana una psicologa a Vallo. Ho studiato medicina alla Sapienza, a Roma, e fin dai primi anni mi sono appassionata all’immunologia clinica, ed in particolare di immunodeficienze. Ho avuto l’onore di avere come relatore della mia tesi il professore Fernando Aiuti, che è stato uno dei primi ad occuparsi di Hiv in Italia.
Raccontaci della tua recente scoperta che hai brevettato. Di cosa si tratta? Perché è innovativa? Ha già aiutato molte persone?
La malattia che studio, è una malattia autoimmune. Significa che il sistema immunitario che è quello che difende il nostro organismo, come per esempio dalle infezioni, non funziona in modo adeguato, anzi in un certo senso è come se fosse impazzito e crea dei danni. In particolare la sclerosi sistemica è caratterizzata da fibrosi cutanea e degli organi interni, che ne altera il funzionamento. Molti dei pazienti sclerodermici, per lo più giovani donne, muoiono per complicanze respiratorie o renali. Come per molte malattie, anche per la sclerosi sistemica non si riesce ancora a capire quale paziente rimarrà stabile per tutto il resto della vita, o migliorerà nel tempo. Ma soprattutto non si sa ancora come identificare chi peggiorerà. Pazienti che noi definiamo ‘progressive’, cioè quelli che peggiorano lo fanno in pochi anni, e capisci che per una malattia di difficile diagnosi, il tempo è importante. Io ho scoperto con l’aiuto dei miei colleghi, che alcuni pazienti sclerodermici presentano un gruppo di geni, la cui espressione è notevolmente aumentata nella cute fin dall’inizio della malattia, quando i pazienti non hanno ancora danni d’organo o fibrosi cutanea, e sono questi pazienti che peggiorano nel tempo. Capire in anticipo quali sono i pazienti che staranno male, e con maggior rischio di complicanze sistemiche gravi, aiuta il medico a iniziare una terapia precocemente. Purtroppo non esiste per questa malattia una terapia specifica. L’utilizzo di tali marcatori, potrà permetterci anche di creare clinical trials per nuovi farmaci. Quando i pazienti vengono reclutati nei clinical trials, la scelta è casuale. Immagina di reclutare pazienti che non svilupperanno una grave forma della malattia. Noi non sapremo mai se la mancata progressione della malattia è un effetto del farmaco che si sta testando o del naturale andamento della patologia. Ancora non abbiamo potuto utilizzare questi marcatori, quindi non posso dire di aver aiutato qualcuno. Ma questa scoperta è stata registrata presso l’ufficio brevetti e speriamo presto di poterla utilizzare. Qualcuno ha già mostrato interesse per questi marcatori. E` chiaro che ci vuole ancora tanto lavoro e tempo, ma siamo sulla buona strada.
Quanto importante è per te il Cilento e quanto ti ha insegnato questa terra?
Tempo fa ho presentato il mio lavoro a un convegno, dove c’era come ospite un professore australiano che ha lavorato per anni in Svizzera e ora lavora a Firenze. Alla fine della mia presentazione mi si avvicina e mi dice in italiano ‘brava’. A quella parola in italiano, mi si è aperto il cuore, abbiamo iniziato a parlare, e mi ha chiesto da quale parte dell’Italia sono originaria. A questa domanda spesso rispondo dal ‘sud, il mio paese è vicino a Salerno’, e se non conoscono Salerno, parlo della costiera amalfitana. In quel caso dissi ‘Salerno’ e lui ripose «Salerno dove?». Risposi del Cilento e lui «che magnifico posto». Parlammo a lungo delle nostre spiagge, dell’ospitalità della gente, delle alici, della nostra mozzarella, dei fichi secchi che lui aveva mangiato e che anch’io adoro. Lui è stato in vacanza da noi e ritorna spesso. Questa terra e le persone che hanno temprato la mia persona mi hanno insegnato tanto. Non è stato facilissimo crescere qui. Mia mamma ha sempre lavorato tanto e fatto tantissimi sacrifici così come noi figli. Sono riuscita a non perdermi e a crescere anche grazie all’aiuto delle persone che ho avuto accanto. Il quartiere dove sono cresciuta è San Pantaleone. Mi sono svegliata per quasi tutta la mia vita al suono delle campane della cattedrale. Ricordo le estati passate a giocare per strada, con gli altri bimbi del quartiere, e c’era sempre qualcuno al bacone, che, anche se non aveva un vincolo di parentela ci teneva d’occhio. Ricordo le feste di San Pantaleo, quando con le altre signore del quartiere pulivano le strade per il passaggio della processione, così come quando finalmente fu riaperta la cattedrale dopo i lunghi lavori di restauro per i danni provocati dal terremoto del 1980. Tutto il quartiere e non solo si mobilizzò per pulire l’interno della chiesa. Ho sviluppato un forte senso civico che spesso non si insegna più e che è molto comune negli States. Ma questo era Vallo degli anni ‘90, e questo è quello che ho imparato dalla gente della mia terra.
Se ti offrissero un posto qui, torneresti?
Mi mancano tantissimo gli affetti, e se tornassi, lo farei soprattutto per stare più vicino alla mia famiglia, ma non ti nascondo che mi piacerebbe anche offrire il mio lavoro alla mia gente e aiutarla. L’idea di ritornare a lavorare in Italia però mi spaventa. Non sono mai scesa a compromessi, ho fatto tutto da sola e con l’aiuto di chi mi vuole bene, ed infatti la mia carriera non è stata sempre in discesa. L’America ti offre tante opportunità e gli americani riconoscono l’impegno e la bravura. Il mio capo dopo tre mesi che stavo lì mi ha stretto la mano dicendo che quello che stavo facendo era davvero fatto bene. Allora il mio inglese faceva schifo e il lavoro che stavo svolgendo, lo stavo ancora imparando. Ero così orgogliosa di me stessa. E` stata la prima volta che ho sentivo quella sensazione, e pure di traguardi in Italia ne avevo raggiunti, ma avevo sempre sentito quella strana sensazione che dovevo ringraziare qualcuno e sentivo come se qualcuno mi stesse facendo un piacere. A Roma, ho avuto degli ottimi maestri, con cui continuo ad avere ottimi rapporti, e ho sempre creduto che i miei professori Italiani se mi dicevano che “ero capace” lo dicessero più per affetto.
Negli States molti migrano per realizzarsi professionalmente. Cosa ha l’America che l’Italia non ha?
L’America, come molti altri paesi europei, investe tanti soldi sulla ricerca e sui giovani. Io non credo che avrei potuto fare in Italia quello che ho fatto negli States. In America ti è data l’opportunità di crescere e di scegliere. In Italia purtroppo crescono in pochi, e non puoi scegliere cosa è meglio per la tua carriera e cosa davvero ti piace fare. In America le gerarchie esistono, ma il mondo accademico è accessibile a tutti. Certo non puoi rilassarti mai, è tutto molto competitivo. Quindi anche lì devi avere una sorta di resistenza, ed io credo che noi studenti italiani abbiamo davvero imparato a sgomitare e a farci strada. Io ho sempre pensato che in Italia si laureano: i raccomandati, i bravi, e di questi ultimi soprattutto i temerari. Chi non riesce a laurearsi o chi impiega tempo a farlo o perché non ha voglia di studiare o perché ha difficoltà ad accettare il sistema. Non è ancora pronto a sgomitare per quello che desidera, e molti rinunciano perché stremati.
Cosa ti senti di consigliare ai giovani italiani, in particolare ai cilentani? Restare tentando di costruire una realtà migliore o andarsene per inseguire i propri sogni?
Mi sono sempre chiesta se ci vuole più coraggio a rimanere o a partire. Nonostante sia convinta che chi parte è un coraggioso, io credo che è ancora più coraggioso chi ritorna. Chi resta e non accetta il sistema, è un pazzo e ne conosco tanti e li ammiro molto. Il mio consiglio è di andare via ma sicuramente di ritornare. Le nostre esperienze possono arricchire la nostra terra e aiutare le persone che rimangono.
Hai un sogno nel cassetto che vuoi ancora realizzare?
Il mio cassetto è pieno di sogni. Ogni volta che se ne realizza uno, se ne creano altri mille. E sono molto fortunata perché tutti i miei sogni si sono realizzati. Adesso spero di riuscire a ritornare in corsia e a vedere pazienti, ma non ho nessuna intenzione di lasciare la ricerca. So che questo comporta molti sacrifici e tanto impegno ma sento che posso farcela.
©
©Riproduzione riservata