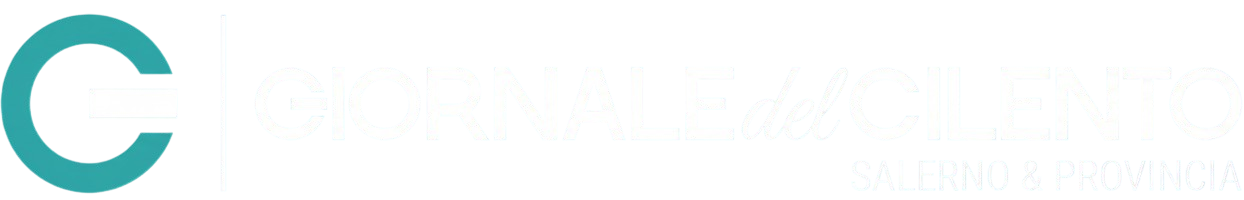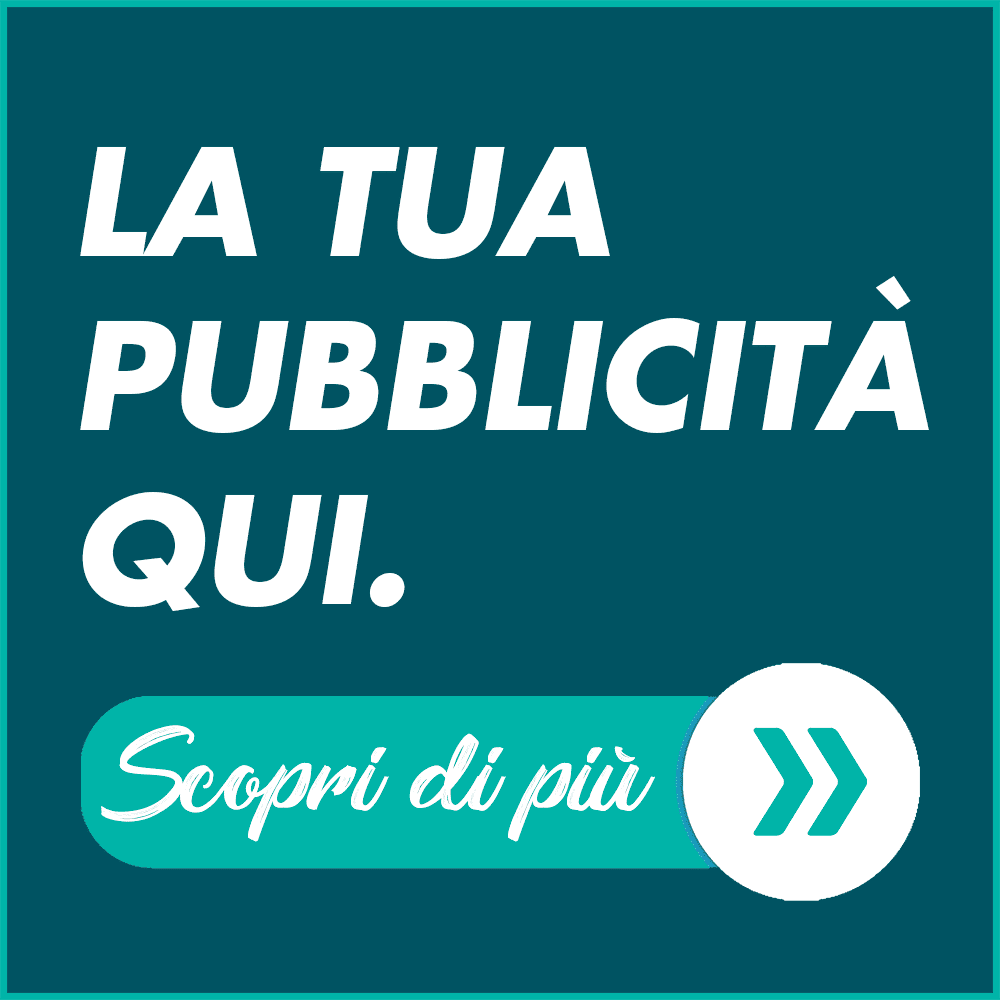Dove c’è una narrazione coerente, cresce il valore di ogni filiera. Il turismo è il codice sorgente dell’economia territoriale.
di Marco Sansiviero, Presidente Nazionale Fenailp Turismo
Per troppo tempo abbiamo confinato il turismo dentro una cornice amministrativa: un “settore” come gli altri, con le sue fiere, i suoi bilanci e i suoi uffici di promozione. È stato comodo definirlo così: un contenitore gestibile, con numeri, tabelle e procedure. Ma quella definizione, oggi, è un ostacolo.
Perché il turismo, nel mondo contemporaneo, non è più un comparto produttivo: è un linguaggio economico. Un sistema di segni e di connessioni attraverso cui un territorio comunica se stesso e genera valore per ogni altro ambito — dall’agricoltura alla cultura, dall’artigianato all’innovazione.
Ogni volta che un luogo riesce a raccontarsi, non promuove solo la propria bellezza: traduce la propria identità in economia.
Un vino locale, ad esempio, acquista appeal non per la sua gradazione, ma per la storia che lo accompagna: il paesaggio da cui proviene, le mani che lo producono, la visione culturale che lo sostiene. La stessa logica vale per l’olio, per l’artigianato, per la gastronomia e persino per l’immobiliare.
Il turismo, in questo senso, non è la “vetrina” dell’economia, ma il codice di comunicazione che le consente di essere compresa e desiderata.
Il problema è che la maggior parte dei territori continua a parlare in un linguaggio frammentato: eventi isolati, campagne episodiche, messaggi scollegati tra istituzioni, imprese e comunità.
Si confonde la promozione con la comunicazione, l’immagine con l’identità, la visibilità con la reputazione. Ma un territorio senza una voce coerente è come un brand senza storytelling: può esistere, ma non può influenzare.
L’errore di fondo è pensare che il turismo “serva” solo al turismo.
In realtà, ogni narrazione turistica efficace agisce come infrastruttura cognitiva: apre mercati, sposta percezioni, valorizza competenze locali e accelera la reputazione complessiva del sistema territoriale.
Là dove si investe in storytelling, cresce il valore percepito di tutti gli altri prodotti. Là dove manca una strategia narrativa, anche la migliore offerta resta invisibile.
Non è un caso se le aree più dinamiche del Paese sono quelle che hanno saputo integrare turismo, cultura e impresa in un’unica visione.
Quando una destinazione diventa un racconto condiviso — e non un catalogo di attrazioni — attiva un moltiplicatore economico che nessuna politica di settore può eguagliare.
È un effetto domino: la percezione attira l’interesse, l’interesse genera fiducia, la fiducia alimenta investimenti, e gli investimenti rafforzano la reputazione.
La forza di un territorio, oggi, si misura nella capacità di articolare una visione che metta in relazione emozione e economia, estetica e impresa, racconto e realtà.
Questo è il nuovo alfabeto competitivo: non quello delle strutture ricettive, ma quello della narrazione identitaria.
Chi lo padroneggia, cresce. Chi lo ignora, resta muto davanti al mercato globale.
Per questo, smettere di trattare il turismo come un settore significa liberarlo dal suo recinto burocratico e riconoscerlo come ciò che è: una lingua che parla di valore, prima ancora che di luoghi.
E come ogni lingua viva, va studiata, esercitata e continuamente reinventata.