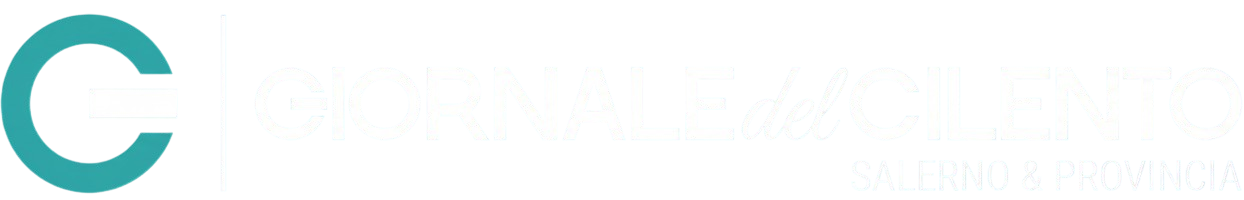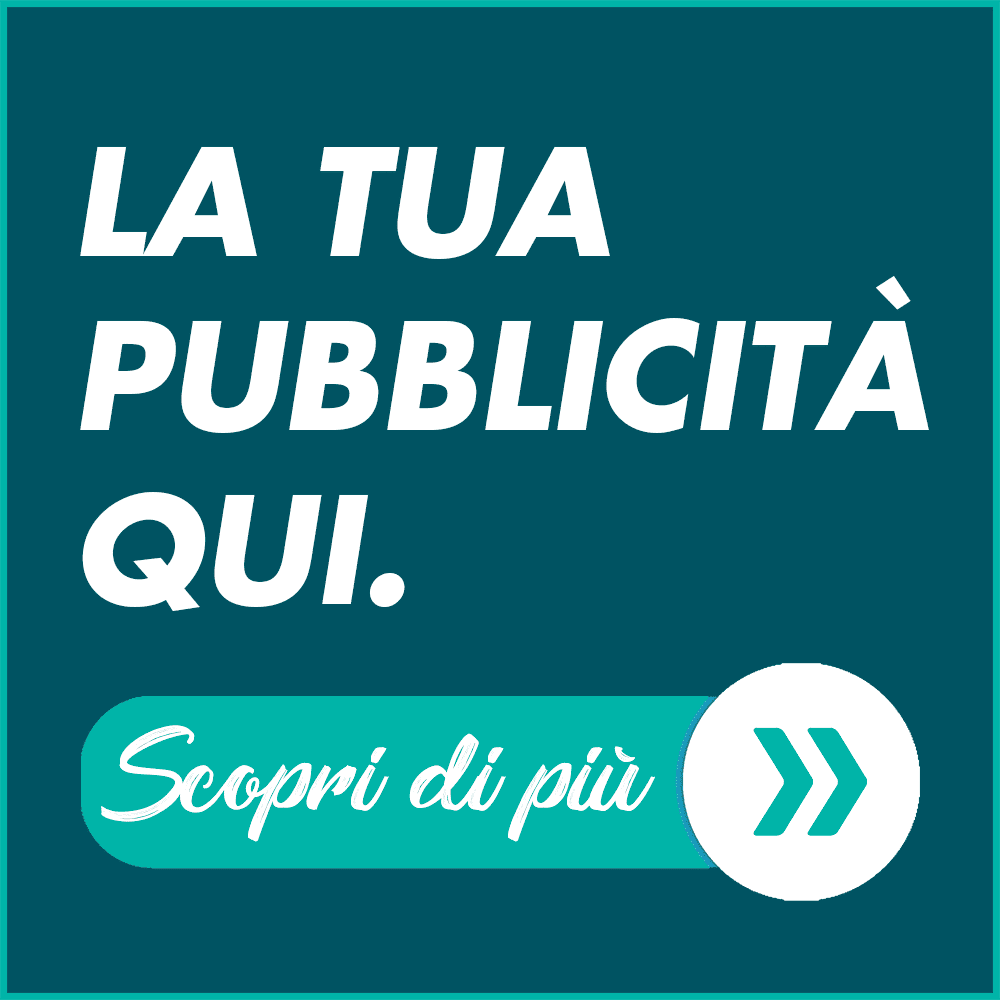“…una focaccia e dell’acqua procurano il piacere più intenso, qualora se ne cibi chi abbia fame. Abituarsi a un tenore di vita modesto e non sfarzoso giova dunque alla salute e fa sì che l’uomo non esiti a riconoscere ciò che davvero occorre per vivere…“. Di tutti i filosofi che hanno parlato di felicità accostata al piacere, Epicuro è stato spesso quello più equivocato, nella storia e tra i suoi contemporanei. Di sfarzoso ed eccessivo non aveva alcuna abitudine. Era piuttosto un uomo modesto e semplice che con gli amici, che andavano a trovarlo nel suo giardino, amava chiacchierare mangiando pane e bevendo acqua. Per Epicuro la felicità si misura con il piacere di ciò che si ha, lo stesso che nelle regioni del Sud Italia si prova e si provava con l’Acquasale, che a vista può sembrare un piatto per riempire lo stomaco, in realtà nella sua semplicità crea felicità e legami nella comunità. I pescatori cilentani raccontano che l’acquasale era il loro ben di dio per fare colazione. Caricavano il pane duro in spalla e prima di partire per la pesca lo bagnavano nell’acqua di mare. Questo piatto prende origini probabilmente da antiche tradizioni greche; ancora oggi, infatti, viene servito come antipasto nelle taverne di alcune isole della Grecia. Tipico del Sud Italia è particolarmente diffuso in Puglia, Basilicata e Campania, specialmente nel Cilento. Semplice e sano, lo preparavano i pescatori ma anche i contadini nel periodo estivo quando andavano a lavorare i campi. La materia prima si trovava sul posto, il pane duro come la pietra. Si metteva in un grosso piatto di coccio e si inumidiva, i più fortunati lo condivano con gli aromi che c’erano, anche i pomodori e l’olio. Tutti lo mangiavano attingendo dallo stesso piatto, rispettando fedelmente quella regola cardine della Dieta Mediterranea che fa campare cento anni: la convivialità. La sua evoluzione o la sua gemella dell’Italia centro settentrionale è la panzanella, che ha molte ricette, diverse a seconda della regione d’origine. Una ricetta anche questa che ha fatto scorrere fiumi d’inchiostro e che discende quasi certamente dal “pan lavato” di cui parla anche il Boccaccio. Anche la panzanella, come l’acquasale, è legata all’usanza contadina di bagnare il pane vecchio e secco per mescolarlo, in questo caso, con le verdure disponibili nell’orto, e a quella dei marinai che la mangiavano a bordo delle loro barche dopo aver bagnato il pane nell’acqua di mare. Origini discusse a parte, oggi l’acquasale prevede l’uso di pare raffermo, pomodori, olio e sale; mentre la base classica della ricetta della panzanella vuole che a questi ingredienti si aggiungano anche cipolla, basilico, cetrioli e aceto. Dunque, ciò che cambia più spesso in base alla regione di provenienza e al modo in cui viene utilizzato il pane raffermo, è il condimento. Un piatto unico e squisito che ha ispirato nei secoli poeti, pittori e personaggi della società. Un esempio di ciò è dato da una poesia del Bronzino, pittore del manierismo fiorentino alla corte de’ Medici nel XVI secolo, il quale esprime il suo amore per la panzanella. E il grande Aldo Fabrizi che alla panzanella dedicò perfino una poesia. Dunque, se la ricetta tradizionale vuole pane senza sale, pomodori maturi, cipolla, sale, olio extravergine d’oliva, aceto e cetrioli, ecco le prime differenze con il resto d’Italia. In Umbria il cetriolo è vietato, così come in altri posti della Toscana non si usa il pomodoro maturo ma i pomodorini. A Roma il pane, invece, non può essere “sciapo” ma salato e la crosta va bagnata senza però spezzettarla, come fanno più su. Anche per le spezie e le erbe aromatiche ci sono molte differenze: chi preferisce l’origano, chi il prezzemolo, o l’erba cipollina e chi ancora la mentuccia. A Lucca e nella Lunigiana, invece, la panzanella è una pasta di pane fritta che nulla ha di simile al pane raffermo con i pomodori. Più umile e povera rimane l’acquasale, che ancora oggi in Cilento viene preparata bagnando il pane prima di essere condito con olio e sale e in alcuni casi aggiungendo i pomodori maturi e l’origano o il basilico. In passato era preparata con il viccio, che era un pane tradizionale che serviva a verificare la temperatura del forno a legna prima di infornare gli impasti. Esistono molte versioni di acquasale anche al Sud. Quella lucana prevede anche la presenza dell’uovo. Nello specifico bisogna ammollare delle fette di pane raffermo o biscottato e condirlo con sale, olio, verdure bollite, uovo strapazzato o in camicia. In alcuni paesi si aggiunge anche il famoso peperone crusco, quello di cui la Lucania è terra ricca. Paese che vai acquasale e panzanella che trovi, entrambi nate in fondo per dare nuova vita al pane raffermo, mescolandolo con quello che avanza in casa. La bandiera tricolore del gusto dell’Italia contadina, ricetta sacra e tradizionale, ancora più buona se a questi ingredienti si aggiunge quello più amato in cucina, la fantasia.
L’acquasale, la bandiera tricolore contadina
| di Marianna Vallone
©Riproduzione riservata