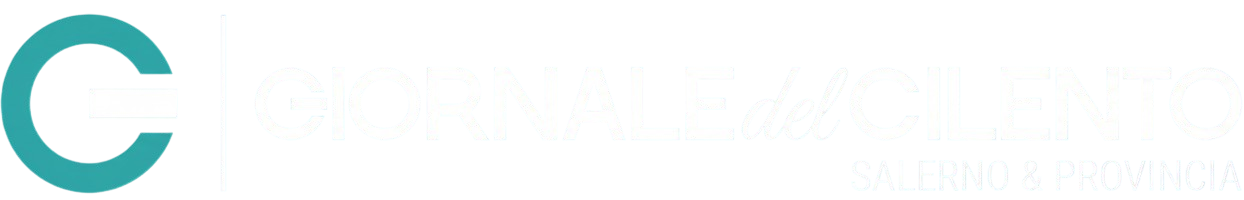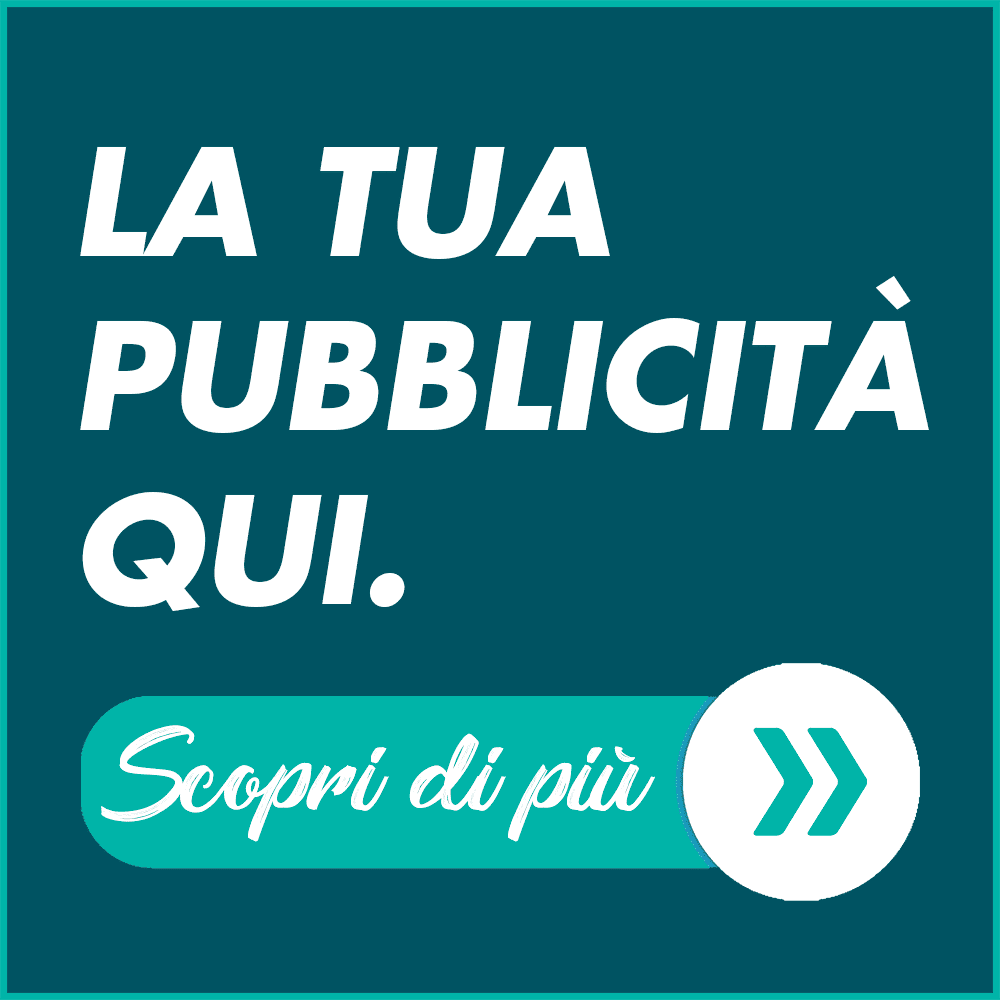C’è un luogo, nel Cilento, dove il tempo sembra essersi fermato. Un luogo in cui la luce del Mediterraneo si intreccia con la maestosità dell’antica Grecia. È Paestum, uno dei siti archeologici più affascinanti d’Italia, custode di tre templi dorici tra i meglio conservati al mondo. Una meta che oggi richiama viaggiatori da ogni parte, incantati dalla sua bellezza austera e dal fascino senza tempo.
Fondata dai coloni greci attorno al 600 a.C. con il nome di Poseidonia, Paestum sorse su un pianoro fertile non lontano dal mare, lungo le vie di scambio che collegavano il Mediterraneo orientale con l’entroterra campano. Ancora oggi il visitatore percepisce l’impianto ordinato della città antica: le mura possenti, lunghe quasi cinque chilometri, proteggono un rettangolo quasi perfetto, dove strade, piazze e santuari raccontano una civiltà raffinata e profondamente religiosa.
I tre templi: capolavori assoluti del dorico
Il cuore pulsante dell’area archeologica è rappresentato dai tre templi dorici, tra i monumenti più iconici dell’archeologia mondiale: il Tempio di Hera, detto anche “Basilica”, il più antico (VI sec. a.C.), con le sue colonne slanciate e massicce, che ancora oggi comunicano un senso di primitiva sacralità; il Tempio di Apollo/Hera II, meglio conosciuto come il Tempio di Nettuno, un capolavoro del V secolo a.C., armonioso e perfetto nelle proporzioni, simbolo stesso di Paestum; il Tempio di Atena, più piccolo ma elegantissimo, che segna il passaggio al gusto classico.
La loro conservazione straordinaria è dovuta anche al fatto che, per secoli, Paestum rimase dimenticata nelle paludi, fino alla riscoperta nel Settecento, quando i viaggiatori del Grand Tour ne fecero una tappa imprescindibile.
Accanto all’area archeologica, il Museo Archeologico Nazionale di Paestum e Velia conserva reperti unici: ceramiche finissime, armi, sculture e soprattutto la celebre Tomba del Tuffatore, con il suo affresco del giovane che si tuffa nell’ignoto. È una delle poche pitture greche sopravvissute, una finestra poetica sulla sensibilità dell’antichità.