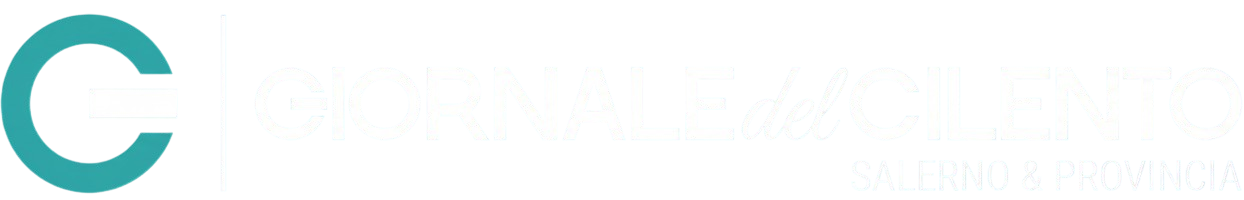L’economia digitale cresce a un ritmo senza precedenti. L’intelligenza artificiale entra nei processi produttivi, le imprese si spostano nel cloud, i pagamenti diventano invisibili, e i servizi pubblici si spostano sempre più online. Ma dietro la promessa di efficienza e innovazione, si nasconde un rischio crescente: quello di una nuova disuguaglianza economica e sociale, costruita non sul reddito o sulla proprietà, ma sull’accesso e sull’uso del digitale.
Il paradosso della crescita digitale
Secondo la Commissione europea, l’economia digitale rappresenta ormai oltre il 20% del PIL dell’Unione e continua a espandersi. Tuttavia, la ricchezza prodotta si concentra in poche mani. Le grandi piattaforme globali – dai colossi del cloud alle aziende che gestiscono i marketplace – catturano gran parte del valore creato, mentre le PMI e i lavoratori autonomi faticano a tenere il passo. È il paradosso della crescita digitale: aumenta la produttività complessiva, ma non la sua distribuzione equa.
Accesso, competenze e territori: il nuovo digital divide
Non si tratta solo di connessione a Internet. Oggi il digital divide è fatto di competenze, consapevolezza e possibilità di utilizzo. In Italia, secondo l’indice DESI 2024, solo il 46% degli adulti possiede competenze digitali di base, con un forte divario tra Nord e Sud, tra giovani e over 55, tra uomini e donne.
Questo significa che una parte consistente della popolazione resta esclusa da opportunità di lavoro, servizi pubblici digitali, formazione e partecipazione economica. La disuguaglianza digitale è quindi anche una disuguaglianza territoriale e culturale, che si traduce in un ritardo complessivo di competitività.
Piattaforme e concentrazione del valore
Le piattaforme digitali sono il simbolo della nuova economia globale. Ma anche qui, i benefici non sono distribuiti in modo uniforme. L’economia delle piattaforme – dai rider alle micro-imprese che vendono online – tende a creare nuove forme di precarietà, in cui il lavoro è frammentato, disintermediato e spesso mal retribuito. Al tempo stesso, le piattaforme accumulano enormi quantità di dati, che diventano nuova fonte di potere economico. Chi controlla i dati controlla il mercato, e quindi la possibilità di creare ricchezza.
La disuguaglianza dei dati
I dati sono la materia prima dell’economia digitale. Ma non tutti ne hanno accesso o controllo.
Cittadini e piccole imprese forniscono dati continuamente, spesso senza consapevolezza o capacità di negoziazione, mentre le grandi aziende li trasformano in valore economico. È ciò che molti studiosi definiscono “data divide”: la separazione tra chi genera dati e chi li utilizza per produrre profitti.
La regolazione europea – con il Data Act e l’AI Act – cerca di riequilibrare questo rapporto, imponendo maggiore trasparenza e responsabilità alle piattaforme.
Il digitale come leva di inclusione
Nonostante i rischi, il digitale può anche ridurre le disuguaglianze, se accompagnato da politiche mirate.
Progetti di educazione digitale, piattaforme pubbliche accessibili, incentivi alla transizione digitale delle PMI e strumenti di innovazione sociale stanno dimostrando che è possibile usare la tecnologia per colmare i divari, non per ampliarli. Esempi virtuosi arrivano anche dall’Italia, con iniziative territoriali di formazione e sperimentazione sull’intelligenza artificiale a servizio delle comunità locali.
Governare il cambiamento
L’economia digitale non è neutrale: amplifica ciò che trova. Può diventare una macchina di inclusione o un moltiplicatore di disuguaglianze. La differenza la fanno le scelte politiche, le strategie industriali e la capacità di immaginare un futuro in cui l’innovazione non sia solo profitto, ma anche coesione sociale.
Perché nella corsa all’innovazione, il vero progresso non è di chi arriva primo, ma di chi riesce a portare tutti con sé.