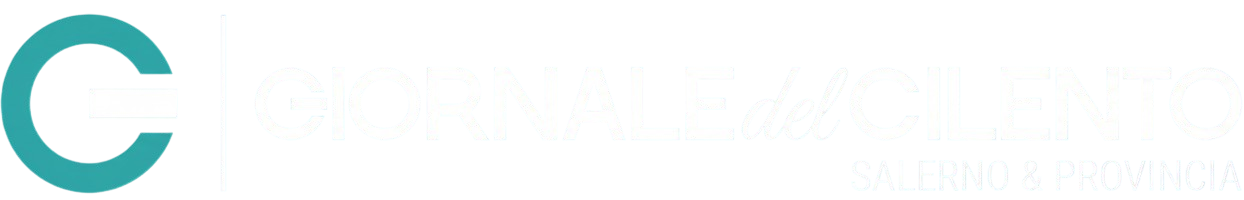A tutti sarà capitato di vedere una pianta di fichi d’India: somigliano molto ai tradizionali cactus, ai quali pure sono botanicamente imparentati. Pochi sanno, probabilmente, che la buccia, resa ostica dalle spine che la ricoprono interamente, è buona da mangiare. Nel basso Cilento, per esempio, la buccia diversi anni fa veniva ripulita dalle spine e fritta in pastella, una merenda alternativa per i bambini di ieri. Anche oggi, una delle ricette più note per mangiarle, è in agrodolce, a conferma che di questo frutto non si butta via niente. Neanche le pale, buone da mangiare saltate in padella con i pomodorini. I fichi d’India sono un frutto prelibato, consigliato per arricchire la propria dieta di fibre, originari del Messico e diffusi poi nelle aree del Mediterraneo, sono apprezzati soprattutto da chi abita in Calabria e Sicilia, che ne conosce le straordinarie proprietà. In queste aree, così come in diversi territori della Campania, crescono perfino sui tetti delle case. Simbolo d’identità locale e territoriale, i fichi d’India rossi, verdi e gialli si incontrano lungo ogni strada, abbarbicati a pale immobili e spesso a ridosso delle strade, dando quel tocco selvaggio, tipico delle aree del Sud tirrenico.
Circondato da spine ma con un cuore decisamente buono, la polpa del fico d’india infatti è costituita da acqua, zuccheri, vitamine e minerali che danno vita a una sostanza mucillaginosa che produce gli stessi effetti delle sostanze contenute nella prugna, aiutano l’intestino ad espellere le tossine. I fichi d’India sono composti per l’80 per cento da acqua, il resto sono proprietà buone per il corpo. Sebbene siano utili per l’intestino e coadiuvanti per l’osteoporosi grazie alla presenza di ferro, la loro migliore qualità, come già detto, è quella di essere un frutto depurativo e dissetante. Grazie a due fibre, la pectina e xilosio, abbassa anche i livelli i zucchero nel sangue, sostenendo così anche le persone diabetiche per evitare i picchi glicemici. L’Opuntia ficus – questo il nome scientifico – può raggiungere un’altezza massima di tre metri e con radici molto estese che comunque non vanno oltre i 30 centimetri di profondità. Cresce senza necessario aiuto da parte dell’uomo, senza bisogno d’acqua e senza difficoltà nelle zone caratterizzate da un clima caldo ed arido. Difatti la sua presenza è tipica delle regioni meridionali. Eppure, non sono pochi gli affanni degli agricoltori, non tanto per la produzione, quanto per la raccolta. I raccoglitori di fichi d’india meriterebbero un capitolo a parte. Spine e sole cocente non li spaventano. Armati di cappello, guanti, e coltello, raccolgono i frutti a ritmo serrato, salendo spesso in punti difficili da raggiungere o imbracciando un lungo bastone alla cui estremità viene infilzato un barattolo di latta che toglie buona parte del fico d’india.
Le varietà non sono molte e si differenziano per lo più in base al colore e al sapore. I gialli, chiamati anche sulfarina, sono i meno amati dai siciliani ma anche i più diffusi, e sono i più semplici da trovare. I più saporiti sono i bianchi, o muscaredda, il cui colore fa pensare che il fico non abbia raggiunto maturazione, invece è esattamente il contrario. Sono meno dolci dei sulfarina e hanno una consistenza meno farinosa. Infine ci sono i rossi, i sanguigni, dalla consistenza media ma dal sapore dolcissimo. E i bastardoni? Sono frutti più grossi del normale e sono ottenuti attraverso una tecnica colturale chiamata “scozzololatura”. Ad inizio estate, subito dopo la fioritura, vengono eliminati tutti i fiori e le pale di un anno, la pianta così stressata provvederà ad una nuova fioritura, con meno fiori che maturati in un periodo più piovoso, daranno vita a frutti più grossi, che saranno consumati a novembre e dicembre.